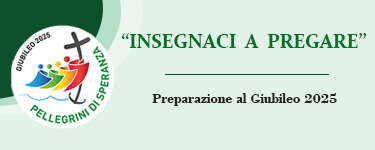Che cos’hanno in comune una festività islamica e una suora che mangia le patatine?
In apparenza niente, se non forse l’ipocrisia di una società che in due differenti contesti fa emergere, con arroganza e un pizzico di grottesco, gli sterili rimasugli di quella che una volta poteva chiamarsi “coscienza religiosa”.
Il passaggio, infatti, dallo stato di cristianità imputabile all’Europa almeno fino al 1700 – e che in Italia continua per più di un secolo, e qualcuno si illude stia continuando ancora oggi – ha fatto sì che ciò che oggi rimane della nostra coscienza, della nostra eredità cristiana sia proprio questo: un vessillo da sbandierare, un totem da ergere contro qualcuno, appunto: un Cristo da sbattere in prima pagina.
Il film, ormai classico, di Marco Bellocchio è forse davvero la miglior metafora per descrivere il nostro stare da “cristiani” nel mondo, fedeli devoti che in realtà incarnano a pieno la figura di Giancarlo Bizanti, il “buon” direttore interpretato da Gian Maria Volonté, che non aspetta altro che avere un capro espiatorio per radunare l’elettorato.
Mai immagine fu più azzeccata, e per due motivi. Innanzitutto, perché è ovvio che, nelle occasioni richiamate, l’indignazione, travestita da fede cristiana, nasconda in realtà semplicemente intolleranza e incapacità di dialogo, la volontà di aggregare le masse attorno a “valori” che, in realtà, sono ben lungi dal definire la nostra esistenza. In secondo luogo perché, paradossalmente, la verità teologica della vita di Gesù Cristo si dischiude davvero nell’immagine del capro espiatorio, dell’agnello immolato. Certo, con la non piccola differenza che il suo è stato un donarsi per la salvezza e il rispetto di tutti, e non per generare un marchio identitario da “sbattere” contro qualcuno.
È proprio questo, invece, quello che sembra succedere attualmente nel nostro bel Paese (e forse non solo). Quella che sembra l’inizio di una classica barzelletta (e forse sarebbe meglio se lo fosse), sintetizza invece il nostro modo di intendere la presenza del cristianesimo nella società e nel dibattito pubblico. Definirsi cristiani, paladini del cristianesimo, significa difendere una reliquia, un cimelio di famiglia, ignorato praticamente in ogni situazione ma che volentieri tiriamo fuori come scusa quando non si hanno (non si vogliono né avere né cercare) altri argomenti per il dialogo.
Ben inteso, si tratta di temi invero decisivi. Nessuno può sminuire, soprattutto oggi, l’importanza del dialogo e della convivenza interreligiosa e del rispetto delle religioni. Ciò che si critica, tuttavia, è l’ipocrisia che si palesa nell’affrontare questi argomenti, anzi, nel parlarne senza riuscire minimamente ad affrontarli (se questo significa fare il primo passo per risolverli). Un’ipocrisia che dipende da un radicale scollamento tra vita privata e coscienza pubblica.
L’ingenua e inconscia convinzione di essere ancora in regime di cristianità – dove essere cristiani significa essere la maggioranza, dove il cristianesimo sarebbe un valore sociale e un dato di fatto – porta a un radicale estrinsecismo tra coscienza personale e coscienza sociale. In altre parole, quello che si è individualmente e quello che si “pretende” o si afferma pubblicamente, viaggiano su due binari paralleli, anzi, talvolta su due binari che corrono in direzioni opposte.
È molto comodo, infatti, dichiararsi cristiani contro il ramadan e non contro gli armamenti, l’evasione fiscale o gli allevamenti intensivi. Non dobbiamo poi nasconderci che se si tratta di vendere e di guadagnare, per sostenere questo malsano e insostenibile sistema consumistico-capitalistico, siamo i primi a strumentalizzare qualsiasi cosa, non solo la religione. Lo spot della ben nota “patatina”, ad esempio, non aveva forse un vago sapore maschilista quando a pubblicizzarla era il protagonista di Supersex? Eppure mi sembra sia andata avanti parecchio…
Quale sarebbe il punto dunque? Perdere tutta la nostra eredità? Tagliare alla radice il legame con il nostro passato? Forse il punto è proprio questo. Siamo sicuri che tutta quella struttura che abbiamo costruito in 1700 anni, quel miscuglio spesso a sua volta ipocrita di potere statale e clericale, sia davvero il cuore della fede cristiana? Sia davvero un elemento indispensabile per vivere la sequela di Cristo nel mondo ogni giorno? Io non penso. Anzi, credo sia proprio questa sovrastruttura ad averci fatto dimenticare che in primo luogo la fede cristiana è vocazione personale, singolare e non un carattere identitario che si riceve nascendo in un luogo, in un tempo o in uno Stato.
Il passaggio semmai, ben più complesso, è domandarsi come declinare nella comunità sociale – in quella casa comune che è di tutti, strutturata e finalizzata al mantenimento del bene comune – quei fondamenti che ciascuno vive personalmente e nella propria comunità religiosa. La perdita di una cultura “ovviamente” cristiana, come poteva essere quella di un secolo fa, conduce a un bivio: continuare a far finta di niente, mettendo in luce una schizofrenia francamente penosa tra pubblico e privato, oppure riscoprire la necessità di decidersi singolarmente per ciò che non è più scontato, non è più imposto, ma deve guadagnarsi fiducia e argomentarsi, in primo luogo con la testimonianza, per poter avere credibilità e voce in capitolo nel discorso pubblico.
Noi stiamo imboccando chiaramente una di queste vie. La speranza è che non passi troppo tempo prima che torniamo sui nostri passi e imbocchiamo con decisione (in tutti i sensi) l’altra.
Stefano Fenaroli